
Teatro dell’Opera di Roma Circo Massimo
Rigoletto
di Giuseppe Verdi
Libretto di Francesco Maria Piave dal dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo (1832).
Daniele Gatti
regia
Damiano Michieletto
MAESTRO DEL CORO Roberto Gabbiani
SCENE Paolo Fantin
COSTUMI Carla Teti
MOVIMENTI COREOGRAFICI Chiara Vecchi
LUCI Alessandro Carletti
REGIA CAMERE LIVE Filippo Rossi
PRINCIPALI INTERPRETI
IL DUCA DI MANTOVA Iván Ayón Rivas
RIGOLETTO Roberto Frontali
GILDA Rosa Feola
SPARAFUCILE Riccardo Zanellato
MADDALENA Martina Belli
GIOVANNA Irida Dragoti **
IL CONTE DI MONTERONE Gabriele Sagona
MARULLO Alessio Verna
MATTEO BORSA Pietro Picone
IL CONTE DI CEPRANO Matteo Ferrara
CONTESSA DI CEPRANO Angela Nicoli
PAGGIO Marika Spadafino
USCIERE Leo Paul Chiarot
** diplomato “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma
Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma
Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma

Rigoletto – Opera di Roma – Circo Massimo Autore: Yasuko Kageyama
Copyright: © Yasuko Kageyama / Teatro dell’Opera di Roma
Questa non è una recensione ma una riflessione, spero pacata, sul teatro, partendo dalla visione e dall’ascolto di un melodramma messo in scena dal Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo, invece che a Caracalla, e allestito su un palcoscenico costruito apposta, in uno spazio che non era destinato al teatro, ma anticamente alle corse di bighe e di cavalli, oggi reperto archeologico da visitare e, di notte, accogliente nascondiglio per incontri segreti tra i digiuni di sesso. Ma è uno spettacolo tutto particolare, questo, la progettazione, cioè, di uno spettacolo che del luogo fa il punto di partenza per inventarsi una drammaturgia. Vero che anche Caracalla non è spazio destinato al teatro. Ma quasi un secolo di rappresentazioni (dal 1937) ne avevano fatto ormai un luogo immaginario anche del teatro. Pochi si accorgevano che non fosse teatro, ma la conversione in luogo teatrale di un luogo che non fu mai teatro, perché in origine un bagno termale, in seguito rovine da visitare con ammirata devozione. E oggi si manifesta assai più che nel passato – se si eccettua la lunga e straordinaria stagione barocca in cui ogni luogo può farsi teatro e, anzi, il teatro stesso, lo stesso edificio teatrale, che oggi crediamo così adeguato, specifico, fu inventato da capo, dapprima sconvolgendo l’idea antica, poi addirittura inventandone un’altra: dall’Olimpico di Vicenza al teatro di Bayreuth, di Sidney, di Amburgo, è tutta una storia di spazio reinventato – oggi, ripeto, oggi più che mai, si manifesta di nuovo il bisogno di teatralizzare qualunque spazio. Bernini, tre secoli fa, fece costruire in legno una copia conforme di Palazzo Farnese a Roma, e poi, di notte, davanti alla piazza trasformata in platea, fece bruciare la copia, sì che al pubblico sembrò che l’intero palazzo bruciasse. Bernini allora non lo sapeva, ma aveva inventato l’installazione. Tre secoli dopo, Iannis Xenakis colloca quattro automobili agli angoli delle rovine del palazzo di Persepolis, quello che il greco Alessandro Magno fece bruciare, commentò una volta, in una conferenza stampa, raccontando le proprie installazioni, o politopi, come lui le chiamava – vendetta di un greco sul persiano invasore. Improvvisamente, quando il pubblico fu disposto nei suoi seggi, le automobili accesero i motori e i fari illuminarono le rovine. Era quello lo spettacolo: e la musica, il rumore dei motori delle automobili.

Persepolis – Iannis Xenakis
Da allora, le installazioni sono uno dei modi con cui l’artista di oggi mostra agli altri che cosa immagina e pensa del mondo. Compreso il visitatore che viene a guardare l’installazione. E anche questo, il coinvolgimento del visitante o dello spettatore, ha un precedente barocco: fu un’altra delle invenzioni di Bernini, che, tra l’altro, era anche commediografo. Nella commedia De’ due teatri ebbe la trovata di mascherare gli attori con gli abiti e le maschere che riproducevano i visi del pubblico, di modo che gli spettatori avevano l’impressione di vedersi rispecchiati sulla scena, come se la scena fosse la riproduzione o il rispecchiamento della platea. Non era, come si potrebbe pensare, solo la ricerca di un effetto sbalorditivo – anche! – ma insinuava, prospettava sul pubblico l’insicurezza della nostra percezione della realtà, alludeva a quanto fossero illusorie le nostre idee su ciò ch’è reale e ciò che non lo è, diventava spettacolo l’inquietante consapevolezza di quanto in sé la realtà sia sfuggente. L’illusione barocca è la raffigurazione, o la metafora poetica, in poesia, a teatro, dell’illusione della vita e, più radicalmente, l’aspirazione a considerarci gli eletti, i privilegiati della vita. Shakespeare e Calderón ce lo hanno rappresentato come nessun altro poeta o drammaturgo o pittore. Tutto il mondo è teatro, dice un personaggio shakespeariano; la vita è sogno, gli fa eco Sigismondo, nella commedia calderoniana che ha per titolo proprio quest’affermazione; noi siamo fatti della stessa materia dei sogni, ci indottrina Prospero nella Tempesta. E proprio Prospero, alla fine della rappresentazione, distrugge gli strumenti magici dell’illusione – abbandona il teatro – e si fa uno di noi. Ma intanto ci ha detto che niente di ciò che vediamo, che viviamo, è davvero come lo vediamo, come lo viviamo.
Nel Gran teatro del Mondo, di Calderón, l’oggetto che all’inizio appariva una culla, da cui nasce l’Uomo, si rovescia e diventa il suo feretro. Nella poesia metafisica inglese, ma anche in Shakespeare, si gioca molto con la rima womb/tomb, grembo/ tomba. Ogni realtà ha il suo doppio. Pindaro ci dice che l’uomo è l’ombra di un sogno. Il teatro barocco ne fa il suo punto di partenza, la verità della non verità dell’essere. Ed è ancora solo teatro, illusione, il teatro che si rappresenta nei teatri del mondo, anche quando sembra lo specchio della realtà. Perché il teatro è sempre una rappresentazione simbolica della realtà, mai la sua riproduzione realistica e conforme. Anche quando la scena sembra riprodurre, infatti, la realtà così com’è, ne rispecchia solo una copia, fa del realismo la sua cifra stilistica, non la chiave di una riproduzione fedele. Non è forse una caso che il più riuscito dei film del neorealismo italiano sia La terra trema di Visconti, nel quale l’esaperazione stilistica tocca quasi i vertici di un estremo estetismo: il reale come stile, non come verità. Si pensi alla Giovanna d’Arco di Dreyer o alla Corazzata Potëmkin. Nel teatro greco gli attori erano tutti uomini e indossavano maschere. Erano tutti uomini anche nel teatro elisabettiano. Nel teatro giapponese il Nô prevede solo attori, il Kabuki dapprima solo attrici. Il teatro indiano sembra risalire addirittura al secondo millennio avanti Cristo e ha un carattere rituale. È solo dal naturalismo ottocentesco che il teatro è inteso come rispecchiamento della realtà. Ma dura poco. Il simbolismo, prima, Pirandello, Brecht, demoliscono le strutture realistiche della rappresentazione. In ogni epoca il verso e il canto sono elementi fondamentali del teatro.

Apollo e Dafne, Dosso Dossi
L’atto che recita in versi non è più realistico dell’attore che canta. Il teatro moderno ha fatto dell’assenza di realismo la sua cifra espressiva. Si osservi, del resto, un quadro come Apollo e Dafne di Dosso Dossi. Che ci fa una viola da braccio tra le mani di Apollo? Ovvio che si tratta di un’allusione simbolica, non di una rappresentazione realistica del dio: la viola da braccio è la musica, la poesia, l’arte, prerogative del dio. Il bello è che, proprio per questo, la viola ci appare appropriata, non anacronistica.
È in questo panorama artistico e culturale, molto schematicamente qui riassunto, che va inteso lo spettacolo visto al teatro che il Teatro dell’Opera di Roma ha costruito sul lato del Circo Massimo che fa angolo con Via di San Teodoro. Dal lato opposto, dunque, a quello delle Terme di Caracalla, sulla Passeggiata Archeologica. In questo spazio Damiano Michieletto ha allestito il Rigoletto di Verdi, concertato da Daniele Gatti. E ha voluto inscenarlo con un’idea di teatro che è quasi la realizzazione di un metateatro, di una riflessione sul teatro, sul fare teatro, anzi di come si fa o, forse, si deve fare teatro: assimilando qualunque spazio, qualunque evento, nello spazio che si fa luogo di un’azione teatrale. Partendo, dunque, dall’idea di decostruire l’impianto drammaturgico di Hugo e Verdi, per ricostruire una vicenda rinascimentale nella vicenda sconvolgente di un oggi che ripropone il dilemma e la lacerazione di quell’ieri. L’idea non è nuova.
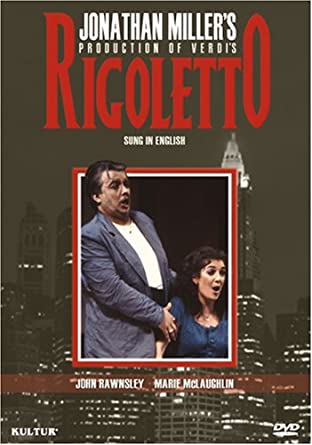
Rigoletto, Jonathan Miller
Nel 1982 Jonathan Miller per la English National Opera mise in scena al teatro Coliseum di Londra un Rigoletto trasferito dalla corte rinascimentale di Mantova alla corte mafiosa di Cosa Nostra, nella Little Italy di New York. Lo spettacolo fu veduto anche in Italia, a Bologna. Del resto, se ci si riflette, già il Rigoletto verdiano trasferisce l’azione dalla corte del Re di Francia alle più ridotte dimensioni di una corte ducale padana. Mantova, nonostante il suo splendore, non è Parigi, e le sopraffazioni di un sovrano assoluto, come era Francesco I, non sono le sopraffazioni di un potentello marginale, di un signorotto di provincia, quasi un galletto italiano ante litteram, come il Duca di Mantova. Si pensi perfino a I vitelloni di Fellini. In bocca al Duca udiamo espressioni volgarotte come le potremmo udire da un bellimbusto che rimorchia una straniera sulla spiaggia di Rimini, e le dice il Duca a Maddalena, la puttana, che lo ha rimorchiato e che è sorella del killer borgognone Sparafucile: “amabile figliola”. Geniale invenzione linguistica di Piave. Ciò che resta del dramma di Hugo è comunque la denuncia di un sopruso politico. Ma una cosa è, però, il sopruso di un sovrano assoluto, e sovrano di una grande Nazione come la Francia, un’altra la prepotenza del signorotto quasi di periferia, di un duca, la cui sopravvivenza dipende proprio dalla politica dei sovrani di quei grandi Stati che lo circondano, Francia, Spagna, Milano, Venezia, lo Stato della Chiesa. Ma Jonathan Miller si muoveva in ogni caso all’interno di una impostazione teatrale tradizionale, realistica, anzi iperrealistica, com’era ancora tradizione dei teatri inglesi.
Damiano Michieletto, che anche lui trasferisce la vicenda all’interno di una banda di gansters, imposta invece la sua messa in scena con parametri teatrali totalmente nuovi. Appena uno si siede nell’immensa gradinata il colpo d’occhio è mozzafiato. Di lato le rovine del Palatino, di fronte il palcoscenico, gigantesco, e davanti al palcoscenico, lo spazio dell’orchestra, dilatatissimo: ai lati, e davanti la scena, per permettere il distanziamento fisico dei suonatori. Il fondale è occupato da un grandissimo schermo, come se ne vedono nei drive-in. Le solite proiezioni, uno pensa, ormai è la moda. Ma appena comincia l’opera ci si accorge che l’idea è un’altra. Due cameramen seguono i cantanti attori nei loro movimenti e li riprendono. Sullo schermo appaiono, ingigantite, le loro immagini, i loro gesti, le espressioni dei loro volti. E’ sì come un film, ma il film lo si vede nel momento stesso in cui viene girato e proprio quell’essere proiettato nel momento stesso in cui si girano le scene è ciò che diventa così teatro. È teatro perché il film lo si vede nel suo farsi, perché i movimenti degli attori sono seguiti a vista dalle macchine da presa, e tutta la finzione della recita è finzione a vista d’occhio, il pubblico la vede e ne prende atto: non insinua l’illusione che si stia guardando una realtà effettiva, ma si mettono subito le carte in tavola, ciò che vedete è finzione, è una rappresentazione simbolica della realtà.

Autore: Kimberley Ross
Copyright: © Kimberley Ross
Informazioni provenienti da IPTC Photo Metadata.
Rigoletto è forse l’opera, se non più cupa, certo più noir di Verdi. Era già noir il dramma (chi sa perché nel programma di sala Michieletto lo chiama “romanzo”) di Hugo, Le roi s’amuse, il re si diverte, andato in scena a Parigi nel 1832, sotto Luigi Filippo. La denuncia politica è la denuncia degli abusi del potere assoluto, delle ingiustizie sociali dell’ancien régime, si spera che il nuovo Re cambi politica. Ma non la cambiò, e il dramma di Hugo fu censurato, proibito e tolto dalle scene. Luigi Filippo sarà pure stato un re costituzionale, ma in ogni caso vedere denunciati i soprusi di un re sulla scena era troppo anche per lui. Gli spettatori dell’Ottocento coglievano perfettamente l’allusione politica attuale anche in un’azione di tre secoli prima. L’ambientazione rinascimentale rischia oggi, però, di non far percepire al pubblico né l’allusione politica né questo tono cupo, visionario, soffocante, del dramma. Perché la bellezza delle scene e dei costumi occulta la sostanziale violenza dell’azione. Michieletto riscrive, perciò, sceneggiatura e drammaturgia: sulla scena, al posto di fondali, porte, specchi, archi, vediamo sei automobili americane e un furgoncino. Sulla destra una giostra: il buffone è un giostraio. Ma il colpo di genio si ha nel terzo atto. Piave colloca la scena sulle sponde del Mincio, una “casa mezzo diroccata” che alberga una “osteria” e le stanze di Sparafucile e di sua sorella Maddalena, prostituta che attira i clienti da rapinare. Squallore estremo, già nel libretto – la musica vi aggiunge la tensione di un clima da thriller, da noir. Verdi mostra più volte, nel suo teatro, di prediligere ambienti equivoci, scene di ambienti degradati o infimi, soldataglia, patiboli, briganti: Masnadieri, Un ballo in maschera, e questo Rigoletto. A dare qui l’aspetto attuale, contemporaneo, e non di un elegante rinascimento, di questo squallore, la “casa mezzo diroccata” diventa una roulotte. Maddalena è una bellissima, avvenente, provocante, seducente Martina Belli, in minigonna, seni prosperosi in mostra, che attua magnificamente la sua parte, sembra uscita da un film di Fellini o di Pasolini, le Notti di Cabiria o Mamma Roma. Ed è bravissima nel mimare i gesti adescatori di una prostituta di strada. Ed è proprio la recitazione ciò che più attrae di questo spettacolo. I primi piani proiettati sullo schermo ne fanno cogliere tutte le finezze.

Rigoletto, Martina Belli, Maddalena e Sparafucile ph Yasuko Kageyama
Per esempio, il trasformarsi del viso di Gilda, una straordinaria Rosa Feola, forse la migliore attrice in campo, dall’espressione ingenua, di ragazza innamorata e spaurita del primo atto all’amara consapevolezza dell’ultimo. In un mondo di sopraffattori, lei chiede solo di non essere violata, sopraffatta, di essere lasciata decidere per sé. Meglio la morte che quella vita di perenne vittima degli altri. Roberto Frontali è un Rigoletto sofferente fin dalla prima scena, un frustrato, uno schiavo, che s’illude per un attimo di potere sopraffare il suo sopraffattore. I primi piani che lo mostrano ansimante o ferito e contuso dalle percosse dei cortigiani che lo accecano con una maschera e gli rapiscono la figlia: bellissima la scena del gruppo mascherato che si prepara a rapire Gilda e scorto Rigoletto lo attornia, lo obbliga anche lui a mascherarsi e lo sequestra, lo colpisce. Così come impressiona la vista di Gilda sorpresa nel suo letto e rapita e scaraventata dentro un furgone. Ma tutti bravissimi gli attori cantanti – assai più che cantanti attori e – finalmente! – sembra restituito l’originario melodramma, il recitar cantando, si badi: recitar cantando, non cantare recitando, è il recitare lo scopo, non il cantare – ebbene, questi bravissimi attori cantanti sono tutti perfettamente in ruolo. Dal cupo Sparafucile di Riccardo Zanellato al fosco Monterone di Gabriele Sagoma, all’ambiguo e sfuggente Marullo di Alessio Verna, alla disinvolta Giovanna di Irina Dragoti. Forse un po’ ingessato, monocorde, è invece proprio il Duca di Mantova – capo gangster di Iván Ayón Rivas, anche se impeccabile nel canto. Ci si chiede solo se il misfatto criminale di una banda, invece che il crimine di un potere politico, non tolga un po’ di forza alla denuncia sociale e politica sia di Hugo sia di Verdi. Tuttavia la sopraffazione, la violenza di un gruppo al di sopra della legge impressiona lo stesso, colpisce come una pugnalata al petto. Unica liberazione il sogno, la visione dell’irrealtà che consola. E’ la visione finale che Rigoletto ha di sua figlia ancora viva, e sorridente, a restituirci in pieno la commozione del sopruso subito.
E la musica? Qui veniamo a quello che, naturalmente, è il lato debole di una simile messa inscena: la musica. All’aperto, e in un luogo senza pareti riflettenti, anche l’amplificazione non rende giustizia all’esecuzione musicale. Tuttavia, entro questi limiti, nonostante queste insufficienze esteriori, ineliminabili e non dovute agli interpreti, Guido Gatti, che ha concertato l’insieme, ha saputo imprimere alla sua interpretazione quella concitazione, quell’intensità già quasi espressionistica, che la partitura richiede. E non sarà mai ringraziato abbastanza per avere ristabilito il “piano” all’attacco di “Vendetta, tremenda vendetta”. Non è ultimo vanto della rappresentazione romana, poi, avere sfidato condizioni che parevano volerla impedire. Non solo per la situazione tragica di questa pandemia, che obbliga a misure di distanziamento fisico (fisico! non sociale, come spesso inopportunamente si sente dire), ma anche per le incomprensioni, va denunciato, che la classe politica italiana sembra continuare a nutrire nei confronti del mondo dello spettacolo: più divertimento che cultura, avremmo, infatti, voluto non sentirci dire da un Presidente del Consiglio che musicisti e attori “ci divertono”. Ma la verità è che forse in quella sede si preferiscono altri tipi di divertimento. Il calcio, per esempio. O si ubbidisce, forse, ad altre pressioni economiche. Il presidente Mattarella, però, intervenuto ad assistere allo spettacolo, e dal pubblico applauditissimo, chi sa, ha voluto anche ristabilire appunto la corretta gerarchia sociale dei valori della cultura, rispetto ad altri. Lo ringraziamo, proprio per questo. Il pubblico ha applaudito tutto e tutti. Segno che presentare, come ormai si fa da anni, al Teatro dell’Opera di Roma, il teatro moderno, ha finito per convincere anche il pubblico più riottoso, quello del melodramma, che non esiste un solo modo di fare teatro.